A Milano muore Sergio Ramelli, neofascista.
Era stato aggredito il 13 Marzo 1975 da alcuni militanti di Avanguardia Operaia.
Testi
- Giovanni Bianconi, Mi dichiaro prigioniero politico. Storia delle Brigate Rosse.
Era stato aggredito il 13 Marzo 1975 da alcuni militanti di Avanguardia Operaia.
Testi
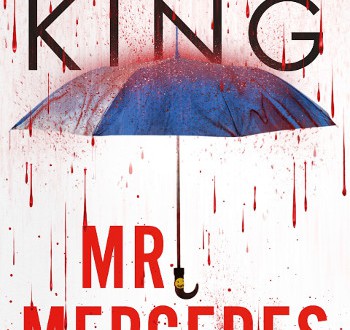
L’omicidio dà il via a tre giorni di scontri tra destra e sinistra in tutta Italia, che causano altre vittime per mano delle cariche della polizia.
Testi
Il 13 marzo 1975 Ramelli stava ritornando a casa, in via Amadeo a Milano; parcheggiato il suo motorino poco distante, in via Paladini, si incamminò verso casa. All’altezza del civico 15 di detta via Paladini Ramelli fu assalito da un gruppo di extraparlamentari comunisti di Avanguardia operaia armati di chiavi inglesi, e colpito più volte al capo; a seguito dei colpi ricevuti perse i sensi e fu lasciato esangue al suolo. La testimonianza resa da Marco Costa durante il processo fu la seguente:
«Ramelli capisce, si protegge la testa con le mani. Ha il viso scoperto e posso colpirlo al viso. Ma temo di sfregiarlo, di spezzargli i denti. Gli tiro giù le mani e lo colpisco al capo con la chiave inglese. Lui non è stordito, si mette a correre. Si trova il motorino fra i piedi e inciampa. Io cado con lui. Lo colpisco un’altra volta. Non so dove: al corpo, alle gambe. Non so. Una signora urla: “Basta, lasciatelo stare! Così lo ammazzate!” Scappo, e dovevo essere l’ultimo a scappare.»
A sua volta Giuseppe Ferrari Bravo rese la seguente testimonianza:
«Aspettammo dieci minuti, e mi parve un’esistenza. Guardavo una vetrina, ma non dicevo nulla. Ricordo il ragazzo che arriva e parcheggia il motorino. Marco mi dice: “Eccolo”, oppure mi dà solo una gomitata. Ricordo le grida. Ricordo, davanti a me, un uomo sbilanciato. Colpisco una volta, forse due. Ricordo una donna, a un balcone, che grida: “Basta!”. Dura tutto pochissimo… Avevo la chiave inglese in mano e la nascosi sotto il cappotto. Fu così breve che ebbi la sensazione di non aver portato a termine il mio compito. Non mi resi affatto conto di ciò che era accaduto.»
Pochi minuti dopo l’aggressione, un commesso vide il corpo coperto di sangue e allertò la portinaia del palazzo di via Amadeo dove il giovane abitava. La portinaia, riconosciutolo, avvertì la polizia e i soccorsi medici; un’autoambulanza lo portò all’Ospedale Maggiore dove fu sottoposto a un intervento chirurgico, della durata di circa cinque ore, nel tentativo di ridurre i danni causati dai colpi inferti alla calotta cranica.
Il decorso post-operatorio di Sergio Ramelli fu caratterizzato da periodi di coma alternati ad altri di lucidità; le complicazioni cerebrali comunque indotte dall’aggressione lasciavano i sanitari dubbiosi sul recupero delle piene funzionalità fisiche. La morte sopraggiunse 48 giorni dopo l’aggressione, il 29 aprile 1975.
Web
La sede dell’IDI è in Via Chiaravalle, a due passi dal duomo. Ore 19:15. Il custode dello stabile vede passare un giovane in loden e una ragazza, pochi attimi dopo tre altri uomini: sembrano studenti o giovani professionisti, non presta loro attenzione. Salgono rapidamente le scale fino al terzo piano, nascondono i visi coi passamontagna. Nei locali dell’istituto, dieci persone: il direttore, Gastone Flandoli, cinque impiegati, tre soci, un tipografo in attesa delle disposizioni per alcuni stampati. Quando la porta si apre, nessuno si volta a guardare. Un attimo dopo, al centro della stanza ci sono la ragazza e l’uomo, in pugno stringono le pistole. Alle loro spalle arrivano gli altri, mascherati e armati. Costringono i presenti faccia al muro, uno entra nell’ufficio del direttore e lo spinge nel gruppo dei prigionieri. Racconta Flandoli: «Ho pensato a una rapina e ho detto: “Vi siete sbagliati, qui non c’è niente da rubare”. Il giovane col loden mi ha subito rimbeccato: “Sappiamo benissimo dove siamo. State calmi, non siamo banditi”. Ne ho visto uno che tremava come una foglia. Da una ventiquattore hanno tirato fuori delle catene». I presenti vengono incatenati e costretti a entrare nel gabinetto in fondo al corridoio. La donna traccia sulle pareti con vernice spray stella e sigla, un secondo rimane dietro la porta per controllare le scale, gli altri esaminano fascicoli e schedari. Nella valigetta finiscono molti documenti, compresi gli elenchi dei duemila iscritti. Dieci minuti dopo il gruppo è in strada, confuso tra i passanti. Testimoni diranno di aver visto «dei giovani allontanarsi su motociclette di grossa cilindrata». Un’ora più tardi, mentre nei locali dell’istituto i rilevamenti non sono ancora terminati, i brigatisti lasciano un comunicato in una cabina telefonica all’angolo tra Corso Sempione e Via Procaccini. L’istituto, sostiene il documento, è «collegato alle associazioni dei dirigenti, contribuisce alla loro qualificazione e alla loro specializzazione nella politica di sfruttamento e di repressione della classe operaia». Alcuni inquirenti sostengono che ad aver compiuto l’assalto sia stato un gruppetto in qualche modo legato alle bierre, ma in sostanza autonomo. «Tutto sta a vedere se questi nuovi aderenti resteranno isolati o se riusciranno a inserirsi nella vera organizzazione delle Brigate Rosse». I dirigenti industriali temono sequestri, assalti. E chiedono protezione.
Nel pomeriggio un commando di cinque brigatisti, armati di mitra e guidati da Mara Cagol, fa irruzione e libera Curcio con estrema facilità, senza dover sparare una sola pallottola. Alla preparazione del piano ha partecipato il brigatista-informatore “Rocco” (Francesco Marra), e del commando che libera Curcio fa parte anche Moretti.
La giornata nel carcere di Casale scorre tranquilla fino a pochi minuti dopo le 16, quando due auto, una Fiat 124 gialla e una 128 blu, arrivano nei pressi del carcere. Scendono un uomo e una donna dai capelli biondi che suona al portone del penitenziario. Una guardia apre lo spioncino, la ragazza sorride.
«Devo consegnare un pacco a un detenuto» dice.
È giorno di visite e tutto sembra normale, la guardia richiude lo spioncino e apre il portone, ma non fa in tempo ad allungare le mani per prendere il pacco che la canna di un mitra gli si pianta contro il petto:
«Non ti muovere o sparo».
Alle spalle della ragazza spuntano alcune persone vestite con le tute blu da operai, che si precipitano all’interno del carcere e tagliano i fili del telefono. Sempre sotto la minaccia del mitra, la donna costringe l’agente che le aveva aperto a chiamare il maresciallo che comanda le guardie. Il maresciallo sopraggiunge dall’interno del carcere, mentre al piano superiore Curcio vede arrivare di corsa un detenuto che lancia l’allarme:
«Giù nella rotonda ci sono degli uomini armati».
La sua cella è ancora aperta perché la conta non è terminata, e il capo brigatista capisce che l’ora tanto attesa è arrivata. Davanti alle guardie impietrite e impreparate comincia a correre lungo il corridoio e giù per le scale, finché si trova davanti a un cancello chiuso.
Attraverso le sbarre vede sua moglie Mara camuffata con una parrucca bionda e i compagni travestiti da operai. Uno si avvicina e gli passa una pistola. Mara, col mitra spianato, ordina a una delle guardie di aprire il cancello, l’uomo ci mette un po’ a individuare la chiave giusta e quando la trova fa fatica a infilarla nella toppa. Alla fine ci riesce, le sbarre si aprono e Curcio si precipita fuori.
Prima di andarsene i brigatisti chiudono il maresciallo e le altre guardie nell’ufficio matricola. Un detenuto comune che stava pulendo il corridoio chiede di poter uscire anche lui, ma gli uomini del commando gli intimano di non muoversi. Il pacco portato da Mara rimane sul pavimento della rotonda. Più tardi arriveranno gli artificieri nel timore che contenga una bomba, ma quando l’apriranno scopriranno che ci sono solo cartacce.
Sul piazzale del carcere Curcio trova tre macchine e altri compagni ad attenderlo. Sale a bordo della prima, che parte a razzo seguita dalle altre due. Il capo delle Brigate rosse, prigioniero da cinque mesi, è stato liberato con un’azione durata meno di cinque minuti che non ha richiesto un solo sparo.
Tonino Loris Paroli, nome di battaglia “Pippo” è a bordo di una delle auto usate nella fuga, poi abbandonate. Quando vede il suo amico Renato al cambio macchina organizzato al di là del passaggio a livello, tensione e paura finalmente si sciolgono. Ma non c’è nemmeno il tempo per un abbraccio, bisogna correre per allontanarsi il più possibile.
Giungono alla cascina Spiotta che ormai si sta facendo buio. A Curcio vengono tinti i capelli, poi il viaggio ricomincia alla volta della Liguria, fino a una casa sul mare ad Alassio, dove Renato si ricongiunge a Mara. «Allora, finalmente, potei dare libero sfogo alla mia gioia, e anche alla commozione», racconterà.
Al di là dell’aspetto romantico di una moglie che guida l’assalto a un carcere per liberare il marito, l’evasione di Curcio è un successo delle Br che riempie di entusiasmo e soddisfazione anche un militante posato e razionale come Pippo, che festeggia a modo suo: in silenzio, riflettendo su un’azione andata a buon fine e su come si può continuare la lotta armata contro lo Stato borghese, anche dopo il «tradimento» di Frate Mitra, la scoperta di alcune «basi» e gli arresti di diversi compagni, proseguiti fino alla vigilia della liberazione di Renato.
La clamorosa evasione del capo delle BR scatena una tempesta politica. Le polemiche, roventi, investono il governo Moro, il Viminale, il ministero della Giustizia, la magistratura di Torino, la Questura di Alessandria.
Il procuratore generale di Torino Carlo Reviglio della Veneria ammette che la Procura aveva ricevuto segnalazioni sulla possibile evasione di Curcio, ma afferma che erano «generiche», e precisa: «D’altra parte è la prima volta che viene fatta un’azione del genere, dall’esterno».
Il giornalista Giorgio Bocca non crede a quella che definisce «favola delle Brigate rosse», e scrive:
«La storia vera di queste BR non la sapremo mai, come tante altre storie di questa nostra mediocre stagione politica; non sapremo in che parte fanno da loro e in che parte vengono strumentalizzate, quanti vi sono entrati e vi rimangono in buona fede, e quanti vi sono stati infiltrati o corrotti… Questa storia è penosa al punto da dimostrare il falso, il marcio che ci sta dietro: perché nessun militante di sinistra si comporterebbe, per libera scelta, in modo da rovesciare tanto ridicolo sulla sinistra».
L’evasione di Curcio è una nuova conferma che gli apparati dello Stato, pur disponendo di infiltrati e informatori all’interno delle BR, non hanno l’univoca volontà di combattere l’eversione terroristica: c’è chi opera per tenere viva l’insidia brigatista, e c’è chi è attivo per spingere le BR verso il militarismo sanguinario. Infatti, benché abbia riacquistato la libertà, Curcio è il latitante più ricercato d’Italia, e in quanto tale è un leader precario e dimezzato; degli altri due “politici” del vertice brigatista, Alberto Franceschini è in carcere, mentre la latitante Mara Cagol ha le settimane contate.
Quanto a Moretti, è impegnato a Genova nell’organizzare la colonna genovese delle BR che presto insanguinerà il capoluogo ligure.
Web
Testi
I preparativi riguardano soprattutto il controllo degli orari di apertura e chiusura di un passaggio a livello che si dovrà attraversare durante la fuga. Sono rimasti in macchina per un’ora, parcheggiati lungo un viottolo di campagna, senza parlare, in sottofondo le canzoni di Bob Dylan suonate da un registratore portatile, mentre i pensieri di Pippo scorrazzavano dai compagni in galera alla famiglia abbandonata, fino alla paura di non rivedere più nessuno.
Le circostanze che hanno permesso ai gendarmi di mettere le mani sul guerrigliero, si assicura, ancora una volta sono state casuali. La cattura avviene il 12 ma la notizia è resa pubblica due giorni più tardi, lo stesso in cui i carabinieri decidono di comunicare la scoperta del «carcere del popolo» usato per la detenzione di Sossi. Le notizie dal Canton Ticino dicono che Morlacchi è stato preso mentre stava organizzando un assalto al carcere di Chiasso, per liberare compagni accusati del tentativo di rapina e dell’uccisione del brigadiere dei carabinieri Lombardini ed Argelato, presso Bologna. L’arresto è avvenuto la sera di Mercoledì, a Bellinzona, ma ha avuto un prologo nel pomeriggio, a Locarno. Un bandito armato fa irruzione nella sede del Credito Commerciale, s’impossessa di 140 mila franchi e fugge. Scattano le indagini, a sera, i gendarmi entrano nel ristorante della stazione di Bellinzona. Seduto a un tavolo scorgono un uomo con una borsa di pelle. È italiano, ma non li convince il passaporto che mostra intestato ad Artemio Spinelli, milanese. Portato al comando, si scopre che nella cartella ha una decina di carte d’identità in bianco. Arresto. Dalla borsa salta fuori anche la foto di un giovane con dati anagrafici segnati sul retro. L’indomani mattina nell’ufficio del capo della polizia cantonale, Giorgio Lepri, arriva un funzionario italiano: una visita «per normali scambi d’informazioni». Lepri avverte il collega dell’arresto compiuto la sera prima. «Vorrei vederlo» dice il poliziotto. Poi, di fronte all’arrestato, esclama: «Ma questo è Morlacchi, il capo delle Brigate Rosse del Lorenteggio, a Milano». Le indagini si spostano in Italia, la polizia risale al giovane della fotografia trovata nella borsa del brigatista: Vincenzo Anastasi, 27 anni, operaio alla Philips. Agenti si precipitano a casa sua, in corso San Gottardo: è arrestato sotto l’accusa di «partecipazione ad associazione sovversiva, detenzione di armi e munizioni».
Le brigate, nella notte fra Domenica 24 e Lunedì 25 incendiano 5 auto. Spiega il comunicato diffuso 24 ore dopo:
È il primo avvertimento a 5 fieri rappresentanti del progetto controrivoluzionario della FIAT.
Seguono i nomi: Giulio Alimonti, Benedetto Mastroienni, Pier Mario Grisotto, Angelo Trevisano, Battista Nicola; la lista di proscrizione è stata fatta «affinché d’ora in poi essi non possano più muovere tranquillamente i loro passi né in fabbrica, né in quartiere e neppure nelle loro case».
Prosegue il documento:
L’intero fascio delle forze della controrivoluzione sta sferrando un attacco concentrico decisivo alla classe operaia della FIAT. I padroni e le forze politiche governative vogliono strangolare la lotta operaia laddove essa ha raggiunto i livelli più alti di organizzazione e si è posta come punto di riferimento generale, creandosi un’avanguardia armata operante sul terreno dello scontro di potere. La sconfitta della classe operaia FIAT sarebbe quindi un primo passo decisivo verso la sconfitta della intera classe operaia italiana. Questa è dunque oggi la condizione preliminare ad ogni progetto di ristrutturazione economica e di stabilizzazione del regime politico in Italia. In questa guerra, combattuta con battaglie durissime, Agnelli mira a: 1) distruggere l’organizzazione del potere operaio in fabbrica. Per portare questo attacco la FIAT fa uso di diversi strumenti come: il terrorismo economico; l’attacco sistematico e selettivo delle avanguardie politiche e di lotta; le manovre scissionistiche nei sindacati e il rilancio dell’odiato sindacato padronale Sida. 2) Ricostruire e rafforzare la sua struttura di comando per garantire una ristrutturazione nel senso dell’efficientismo produttivista. «I capi devono poter ritrovare la grinta degli anni passati» (dice U. Agnelli).